| Il doppio inganno del capitalismo |
| Dove stiamo andando/3 – La definizione è di Keynes e resta quanto mai attuale. Prosegue il viaggio attraverso i cambiamenti radicali degli ultimi decenni, con il tramonto del potere dello Stato-nazione che svolgeva una funzione determinante nella regolazione dell’economia |
Pierre Carniti
(Terzo articolo di una serie – il primo – il secondo)
Un altro radicale cambiamento rispetto all’epoca del New Deal riguarda “l’insieme”. Cioè un equilibrio internazionale, o per grandi aree, nel cui ambito è lecito attendersi che l’economia nazionale trovi un equilibrio contabile che la renda sostenibile o, quanto meno, l’avvicini ad una situazione di sostenibilità.
Qualunque cosa significhi l’attuale rinascita di sentimenti tribali ed autarchici, cioè politiche del tipo: “Alle tue tende, Israele” (come lo slogan British jobs for British people lanciato dal British National Party, o “prima i Padani”, reiterato dalla Lega) dovrebbe essere evidente che quell’ “insieme” non può più essere racchiuso nei confini dello Stato-nazione. In effetti per quanto i governi cerchino di isolare la propria piccola porzione di globo dalle tendenze e condizioni di scambio globale, le misure che possono prendere hanno efficacia di breve durata, mentre a lungo andare i loro effetti rischiano di essere gravemente controproducenti. Perché fatalmente recessivi. D’altro canto lo “spazio dei flussi” globale rimane ostinatamente irraggiungibile per istituzioni (come i governi nazionali) confinate in un delimitato “spazio territoriale”. Per di più qualsiasi frontiera politica è troppo porosa per pensare che i provvedimenti presi nel territorio di uno Stato siano in grado di resistere a flussi finanziari che si muovono su scala globale.
Marx aveva previsto (o forse constatato) che i capitalisti, pur mossi esclusivamente dal proprio interesse egoistico, avrebbero finito per accettare che lo Stato potesse intervenire imponendo agli imprenditori quei tipi di vincoli che essi individualmente non vogliono e non possono nemmeno introdurre fin tanto che i loro competitori hanno la possibilità di potervisi sottrarre. Marx si riferiva al lavoro minorile ed al salario compresso al di sotto della soglia di povertà. Politiche che se adottate da ogni capitalista per prevalere sui propri concorrenti, a lungo andare avrebbero creato gravi problemi (non solo politici e sociali). Avrebbero infatti finito per creare effetti catastrofici per il sistema capitalista nel suo insieme. Soprattutto nel momento in cui si fossero esaurite le riserve di manodopera e si fosse ridotta o azzerata la capacità di lavoro di operai nutriti, vestiti, alloggiati ed istruiti in modo adeguato. Ne dedusse quindi che queste prassi dannose, ed in ultima analisi suicide, potevano essere evitate solo collettivamente. Naturalmente a tal fine serviva un intervento coercitivo, e dunque sovraordinato rispetto alla volontà del singolo imprenditore. In sostanza, per salvaguardare gli interessi del sistema capitalista i singoli capitalisti dovevano essere costretti dalle autorità costituite, tutti e nello stesso momento, ad accettare delle misure, dei compromessi, rispetto al loro interesse immediato. Dovevano quindi essere obbligati ad abbandonare la concezione del proprio tornaconto istantaneo. Imposto dalla concorrenza senza regole ed orientata dal solo criterio: “arraffa oggi più che puoi”.
Potremmo dire, in sostanza, che Roosevelt ha dato seguito al modello previsto (o per lo meno ipotizzato) da Marx quasi un secolo prima. Più o meno la stessa cosa hanno fatto gli altri pionieri del welfare.Indipendentemente dalle diverse versioni nazionali. Il “glorioso trentennio” (come i francesi hanno definito gli anni che vanno dal ‘45 al ’75) è stata l’epoca in cui l’effetto combinato del ricordo della depressione prebellica e dell’esperienza bellica di mobilitazione delle risorse nazionali (quando Roosevelt ha potuto ordinare alle case automobilistiche americane di sospendere la produzione di vetture private per fabbricare carri armati e cannoni per l’esercito), ha aperto la strada alla possibilità (ed alla necessità) di estensione dell’assicurazione obbligatoria contro le conseguenze dell’affarismo individuale. Ma quel “trentennio glorioso” è stato anche l’ultima epoca nella quale è stato possibile prendere delle iniziative sotto forma di leggi pensate, approvate ed imposte nell’ambito di uno Stato-nazione sovrano. Ben presto infatti è emersa una nuova condizione (innescata dalla prima crisi petrolifera del 1973) ed il numero di variabili uscite (o estratte) dalla sfera posta sotto il controllo del potere statale è diventata troppo grande perché le istituzioni di un solo paese fossero ancora in grado di avallare quella polizza assicurativa contro i capricci del “fato”. Che si manifesta attraverso il mercato. E mentre i ricordi si affievolivano e le esperienze venivano dimenticate, lo “Stato sociale” con la sua fitta rete di vincoli e di regole, ha incominciato a perdere progressivamente il consenso che aveva reso possibile la sua istituzione.
A questo proposito è rimasta celebre l’insistenza di Margaret Thatcher sull’idea che una medicina non aiuta a guarire se non è amara. La versione aggiornata dei suoi tardi epigoni è che le “riforme” per essere davvero utili devono essere “impopolari”. I promotori delle medicine amare di ieri e delle riforme impopolari di oggi hanno evitato ed evitano accuratamente di aggiungere che i rimedi da loro somministrati (liberando il capitale da ogni regola e da ogni controllo ed incatenando al tempo stesso, una dopo l’altra, tutte le forze in grado di moderarne gli eccessi) devono essere inghiottiti solo da alcuni, per curare i malanni di altri. E nemmeno dicono (non è del tutto chiaro se per ignoranza o per furbizia) che questo tipo di terapie prima o poi provoca inevitabilmente disastri che in varia forma ricadono su tutti. Una cosa ormai appare certa. Purtroppo il momento è arrivato. Il “prima o poi” è infatti: “adesso”.
Si capisce bene che per tirarci fuori dalla attuale situazione il necessario cambiamento delle politiche, per risultare risolutivo, dovrebbe essere accompagnato anche da un “cambiamento di valori”. Perché stavolta, a differenza di precedenti episodi di depressione, siamo finiti in un pantano che potrà richiedere più di qualche anno di sforzi e di recessione prima che si riesca ad uscirne. Il grande paradosso è che la sobrietà (necessaria per curare l’economia, risanare i nostri stili di vita, dare un po’ più di sicurezza al futuro dei nostri figli) è clamorosamente contraddetta dall’ottimismo di maniera dei governanti che parlano (spesso a vanvera) di misure per il “rilancio e la crescita economica”. Quasi che bastasse mettere un poco di benzina nei motori. In pratica essi assomigliano a quel pilota che volendo rassicurare i passeggeri sosteneva che il suo aereo non avesse niente che non funzionava. A parte i motori. Insomma è difficile “far ripartire l’economia” se prima non ci si rende conto che sono state proprio le sue attuali forme e le sue sregolatezze a portarci al disastro.
In attesa che questa presa di coscienza inizi a manifestarsi ed a farsi valere (a cominciare naturalmente dall’Europa) bisognerebbe porsi come obiettivo prioritario la riduzione delle diseguaglianze. Sia a scala mondiale che continentale e nazionale. Perché è la condizione imprescindibile per una ripresa economica e sociale vera. Scriveva Keynes (in le “Conseguenze economiche della pace”) che il processo di formazione del capitalismo industriale era fondato su un “doppio inganno”. Esso costringeva infatti i lavoratori ad accontentarsi di una piccola parte della torta che avevano contribuito a produrre, mentre ai capitalisti ne veniva riconosciuta “la maggior parte”. Nel tacito presupposto che essi non l’avrebbero consumata, ma destinata prevalentemente all’accumulazione del capitale in funzione di maggiori investimenti e dunque maggiore occupazione. Il “doppio inganno”, come Keynes sapeva bene, consiste nel fatto che i profitti non sono uguali agli investimenti e gli investimenti non si trasformano necessariamente in maggiore occupazione.
|
giovedì 29 marzo 2012
Miti del capitalismo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
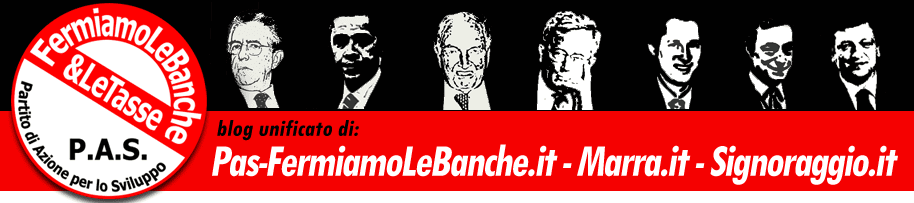

Nessun commento:
Posta un commento